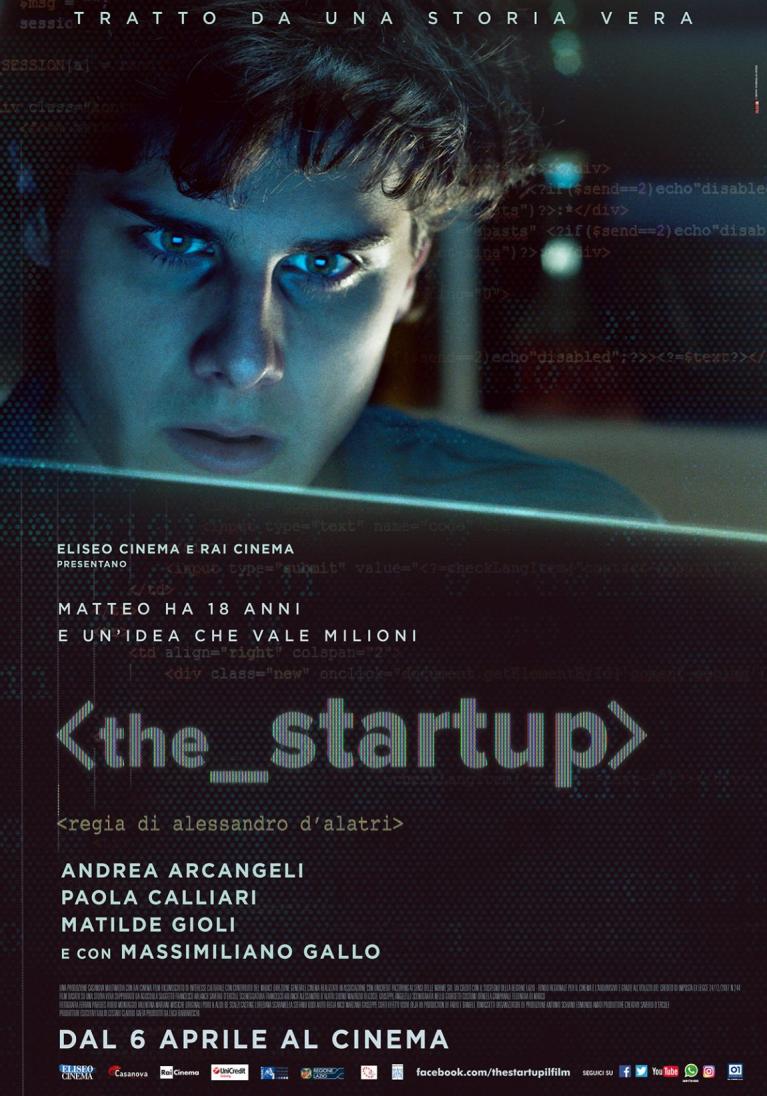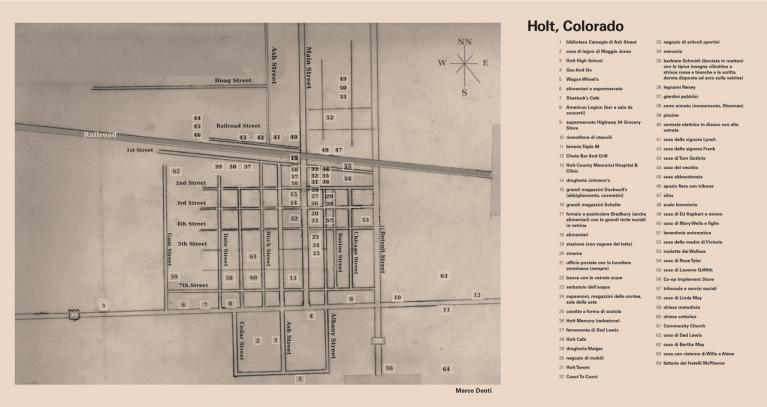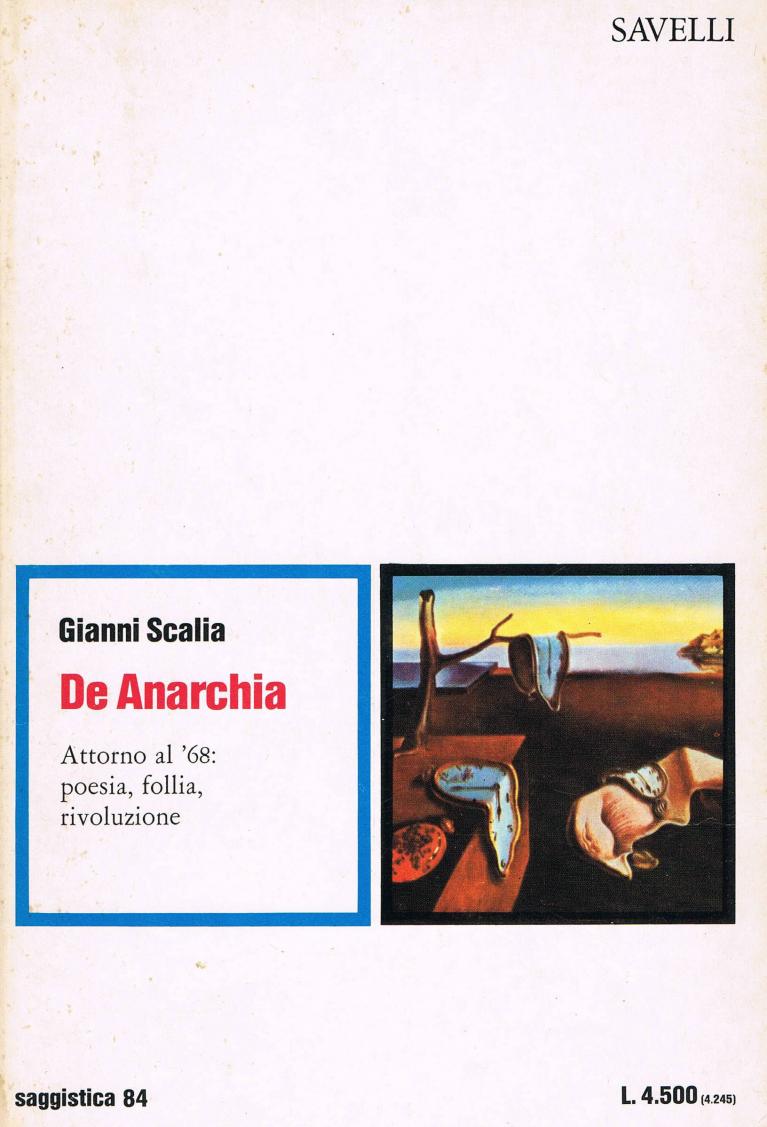Inizio a leggere alle sette del mattino, mentre attendo, in una corsia d'ospedale, la visita medica di una persona cara. Il testo è soffocante, soprattutto se ti sei alzato alle 5 e non hai trovato neppure un caffè aperto. Immediatamente ricordo la stessa sensazione di fronte a Diario di Hiroshima, di Michihiko Hachiya, il medico che racconta lo scenario post-apocalittico della bomba atomica; forse per associazione con la squallida corsia d'ospedale.
La lettura si fa pesante, pure devo rimanere là, incollato al testo, finché la persona che ho accompagnato non esce dall'ambulatorio, ho bisogno di sentire quel senso di oppressione. Si tratta di un libro sulla fine del mondo, provo a trovare respiro nel ricordo dei miei studi giovanili.
Nel 1977 esce La fine del Mondo, libro postumo dell'antropologo italiano Ernesto De Martino. Il libro è pubblicato a sette anni dalla morte dell'autore, quando, per l'antropologo napoletano, la fine del mondo era già da tempo accaduta. Il sottotitolo di quegli appunti, che avrebbero dovuto costituire l'impalcatura di un lavoro futuro, è Contributo all'analisi delle apocalissi culturali. Un anno prima di morire De Martino aveva già scritto un saggio dal titolo: Apocalissi culturali e psicopatologiche sulla rivista Nuovi Argomenti nel 1964.
Il caso della Fine del Mondoè un'ironia, un libro sulla fine del mondo pubblicato post-mortem, ma oggi, secondo Déborah Danowski ed Eduardo Viveiros de Castro, la fine del mondo sembra assumere un significato differente. Da sempre si sente parlare della fine del mondo, annuncio millenarista, memento mori, profezia cosmologica, astrologica, ipotesi geofisica formulata da molti anni, connessa con l'ipotesi della costituzione del mondo. Qualcosa che accade all'umanità dall'esterno, per una volontà trascendente o per una transazione geologica.
Si è parlato a lungo anche della morte di Dio, come nel noto aforisma della Gaia scienza, in cui il folle di Nietzsche annichilisce gli uomini del mercato con l'affermazione perentoria: “Lo abbiamo ucciso noi, io e voi!”.
Ebbene oggi siamo di fronte allo stesso dilemma riguardo alla fine del mondo. Ora che Dio è morto, che ne è del Mondo? Al libro aggiungerei un capitolo su Cassandra e l'avvento della catastrofe su homo demens. Da sempre, di fronte al possibile avvento di una catastrofe ci si divide in due gruppi: quelli che la considerano un fenomeno di poco conto (alla stregua degli uragani che devastano e passano) e quelli che la considerano un fenomeno epocale, accusati di esagerazione o di paranoia. Tra gli esseri umani che praticano attivamente la catastrofe ci sono coloro che lo fanno con un proposito cosciente – come nel caso della Shoah, dello sterminio degli Armeni, delle stragi praticate dagli Khmer rossi – e coloro che lo fanno in modo inconscio, come nel genocidio degli indiani delle Americhe o nel colonialismo. Nel primo caso la finalità distruttiva è praticata con proposito, qualcuno ha definito queste operazioni umane come “male assoluto”; nel secondo caso il proposito cosciente è il progresso, lo sviluppo, la crescita, che, come osservò nel 1968 Gregory Bateson, porta con sé distruzione ecologica.

Illustrazione di Andrew Archer.
Il problema contemporaneo sembra essere Gaia. La trasformazione della Gaia scienza in scienza di Gaia ci mette di fronte a una nuova istanza che riguarda la finitudine: la mia fine potrebbe coincidere con la fine del mondo, non più in senso soggettivo, ma in senso oggettivo: non si tratta della mia fine in Gaia, bensì della nostra fine “consustanziale” alla fine di Gaia: “l'«intrusione» nella nostra storia di un tipo di «trascendenza»” (p. 233). Gaia dunque sarebbe il nome di un evento, un'intrusione nella storia della natura, qui gli autori si riferiscono alla filosofa belga Isabelle Stengers. Si tratta di pensare il “fuori”, un mondo senza pensiero, un'irruzione dall'esterno, una fine della storia. I dati che forniscono gli autori sono molteplici e ben documentati: esplosioni atomiche, riscaldamento del pianeta, accelerazione delle mutazioni e dei cambiamenti conseguenti alle tecnologie umane. Insomma, se fino ad alcuni anni fa si pensava la fine del mondo come un evento “esterno”, oggi si tratta di pensarla come un evento interno, che ci riguarda direttamente, che potrebbe accadere di qui a pochi anni e, quel che più conta, che abbiamo prodotto noi umani. Un passaggio dal “si” al “noi”. O, per usare il linguaggio della clinica psicologica, dall'Es all'Ego. Aggiungerei dall'Es al Super-Ego. Questo movimento progressista e di sviluppo, che caratterizza il “periodo in cui il tempo è fuori sesto e scorre sempre più rapidamente”, si chiama Antropocene. Cos'è dunque l'Antropocene? “È l'epoca in cui la geologia entra in risonanza geologica con la morale, così come avevano profetizzato i celebri visionari Gilles Deleuze e Felix Guattari” (p. 46).
L'Antropocene sembra essere iniziato con la rivoluzione industriale: “Si pensava che l'edificio avrebbe tenuto in virtù del pianterreno, l'economia, ma ci siamo dimenticati delle fondamenta” (p. 46). La rivoluzione industriale porta con sé il modo di pensare illuminista, dal quale emerge che l'ipotesi della fine del mondo possa essere una realtà assai lontana, certamente preceduta dall'estinzione di homo sapiens, anch'essa da pensare in un avvenire indefinito, meno lontano della fine del mondo, ma comunque assai lontano. A questo modo di pensare sembra sfuggire come “l'umanità stessa sia una catastrofe, un evento improvviso e devastante nella storia del pianeta”.
Le apocalissi culturali e psicopatologiche di cui parlava Ernesto De Martino erano la descrizione di un mondo pre-moderno, un mondo contadino dove l'unità mistica tra il soggetto umano e l'oggetto naturale creavano un senso della finitudine inteso come unità indivisibile. L'uomo era parte della natura e i rituali esorcizzavano la fine del mondo, riproducevano una nuova unione in vista della fine, come per allontanarne l'apparizione, anno dopo anno, stagione dopo stagione. La Taranta di Galatina, dove la tarantola morde la spigolatrice scalza, era il luogo di osservazione privilegiato di De Martino. Decine di donne, ogni anno, cadevano in trance sentendo il rimorso (l'essere morse di nuovo dal ragno) di un rapporto tra loro e la terra (la terra del rimorso). Si tratta di un esempio da cui De Martino – coadiuvato dalle osservazioni cliniche di Michele Risso e Letizia Comba – trae riflessioni sulla presenza costante della fine del mondo nella vita contadina del Sud Italia: la distruzione del raccolto, le epidemie, i deliri, la morte precoce dei familiari, i dissidi interni alla comunità.
Oggi questo mondo non esiste più e anche i rituali che lo accompagnano sono finiti. Ogni forma di radicalismo, compreso quel radicalismo scientista e arrogante che domina le nostre università, ci sta conducendo verso la fine del mondo. Déborah Danowski ed Eduardo Viveiros de Castro chiudono il loro libro con un'interrogazione di Isabelle Stengers: "Fino a quando saremo infestati dal modello ideale di un sapere razionale, oggettivo, suscettibile di mettere d'accordo tutti i popoli della Terra, resteremo incapaci di stabilire con questi altri popoli dei rapporti degni di tale nome". (Isabella Stengers, citata dagli autori, p. 236).