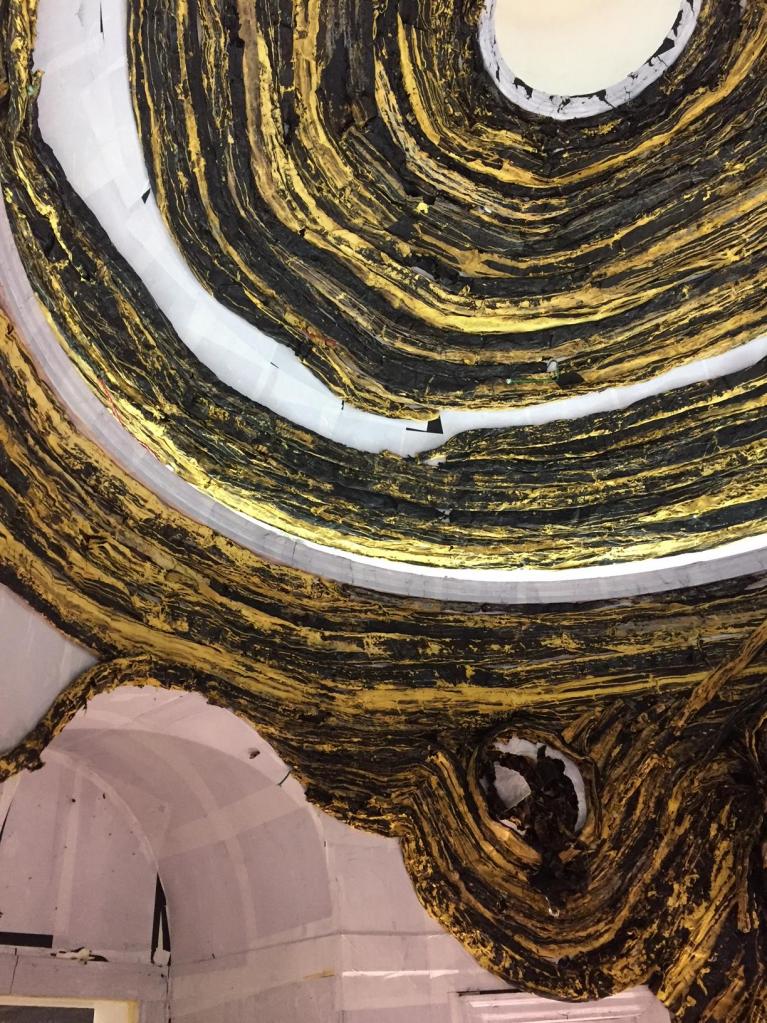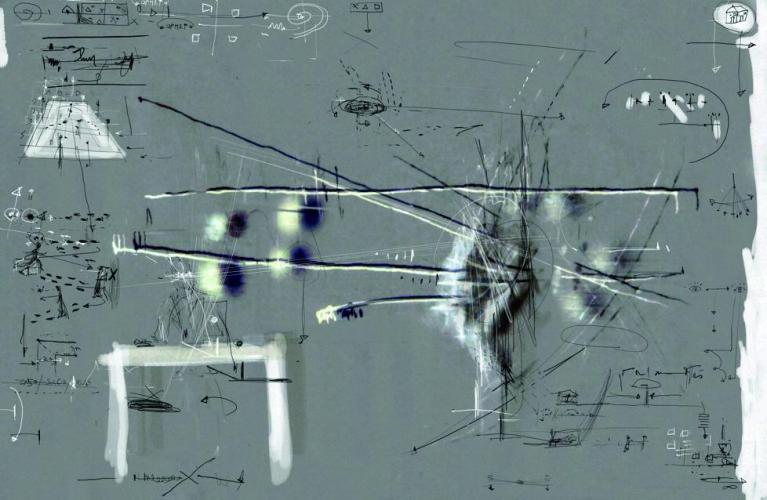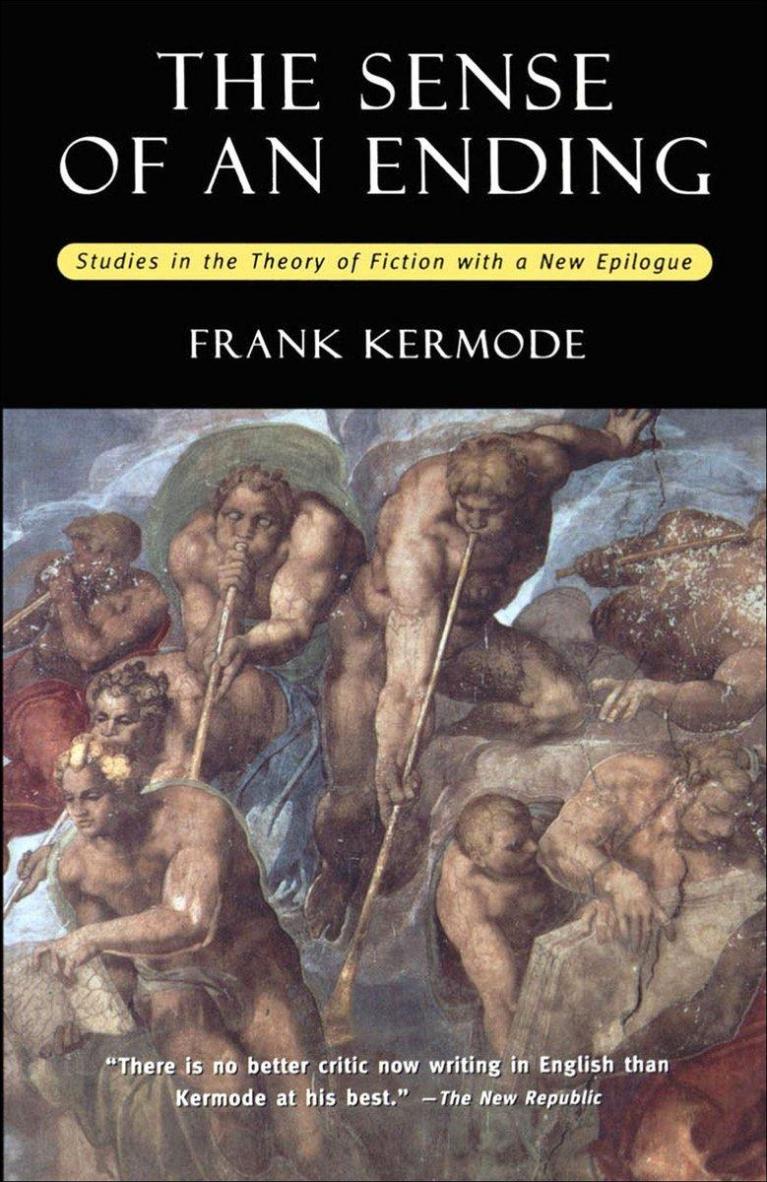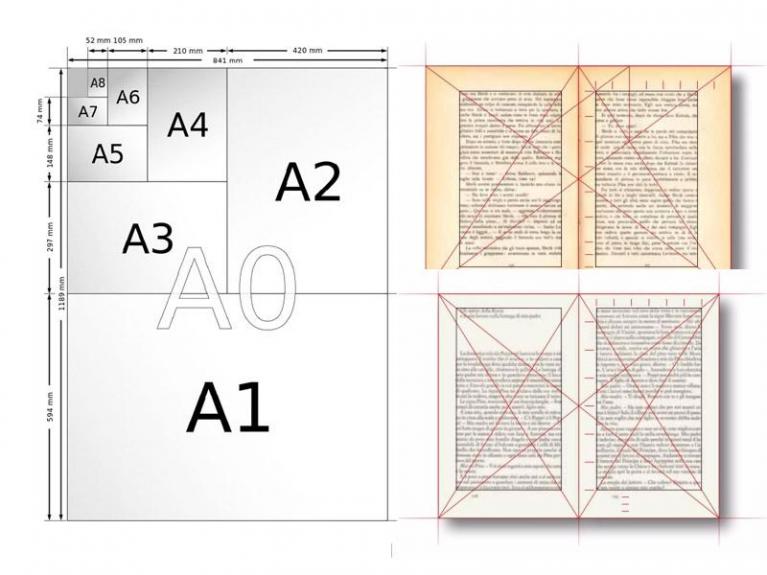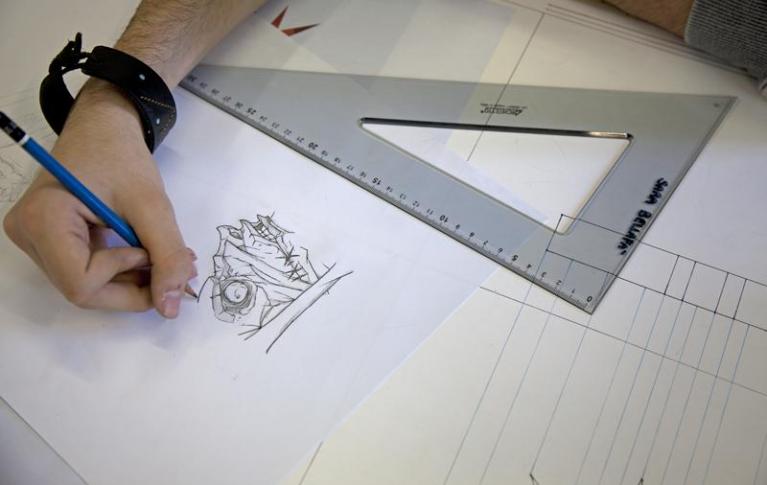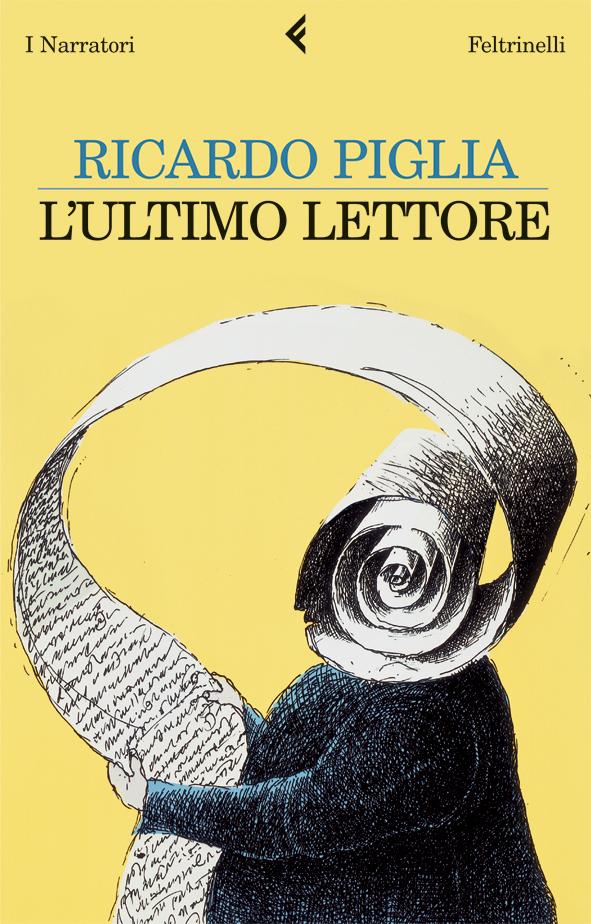


Sparizioni, sequestri, assassinii, attentati, ricerche che si concludono senza concludere, che portano a qualcosa che può anche essere niente, enigmi: i romanzi di Ricardo Piglia, il grande scrittore argentino scomparso qualche mese fa a 76 anni, parlano di questo. Ma così parlando, dicono anche altro, mai niente è semplice, e i livelli di lettura si moltiplicano quanto più il discorso sembra piano e diretto: un discorso di genere, e un genere dominante, il romanzo di investigazione, poliziesco, noir, che poi si combina con altri, secondo i debordamenti e le contaminazioni che il procedere delle vicende narrate richiede. Ma se i primi romanzi riproducono questa complessità nella loro stessa forma (inchieste personali o giornalistiche pe ricostruire storie famigliari; racconti che susseguono o si incastrano gli uni negli altri a fornire le differenti versioni di fatti tutti da costruire, ancor più che da decifrare; macchinari che producono storie non si sa se quanto veritiere di persone che sono di invenzione e insieme realmente vissute; scomparse che sono forse volontarie o forse atti di violenza, come nei due primi e già grandi romanzi Respirazione Artificiale e La città assente), gli ultimi, tra cui l’appena tradotto Solo per Ida Brown, hanno un’apparenza più tradizionale, più ossequiosa, almeno all’inizio, delle leggi del genere, di cui rispettano, senza apparente ironia, i vincoli e i cliché. Piglia non ha la vocazione dell’avanguardista o del provocatore, non gli piace il gesto clamoroso: preferisce muoversi tra le forme con circospezione, misuratissimo e sornione, e complicarle all’occorrenza sempre attento però alla leggibilità, celando abilmente le sottigliezze nel non detto o nell’appena accennato.

Uno degli strumenti ricorrenti per favorire la stratificazione delle letture - oltre alla fittissima rete intertestuale, dichiarata o più spesso mascherata e poco appariscente, di rimandi letterali ma anche, secondo la lezione di Borges, apocrifi ma plausibilissimi -, è il ricorso a personaggi la cui indole o professione li porta a riflettere sugli eventi, la società, la politica e la letteratura. Anche le riflessioni tuttavia restano sempre interne alla narrazione e fortemente contrastate da ipotesi o idee alternative di altri personaggi, impedendo che qualcuna si ponga sopra le altre o addirittura al di fuori della trama, e disseminando le varie interpretazioni in modo che ne costituiscano spesso uno dei motori principali. Si vedano, per esempio, quelle del commissario Croce in Bersaglio notturno e di quasi tutti i personaggi di Respirazione Artificiale, ma si veda soprattutto la figura di Emilio Renzi, giornalista, scrittore e critico, vero e proprio alter ego a cui Piglia affida non solo il compito di dire cose che lui non si azzarderebbe mai a dire a proprio nome, la sua “anima radicale”, ma persino il ruolo di titolare dell’autobiografia in tre volumi (Los diarios de Emilio Renzi, l’ultimo dei quali postumo, di prossima uscita) nei quali lo scrittore ha condensato e organizzato i 357 quaderni del diario tenuto per sessant’anni, dall’adolescenza alla vigilia della morte (come Julien Green, Paul Léautaud, Paul Valéry e altri maratoneti della scrittura quotidiana...), che speriamo di veder tradotti quanto prima.
In Solo per Ida Brown questa dimensione è amplificata dal fatto che gli eventi si svolgono in buona parte in un campus universitario degli Stati Uniti che ricalca la Princeton in cui Piglia ha insegnato a lungo, dove Renzi è stato invitato su insistenza dell’Ida Brown del titolo, sua collega agguerritissima, che diventerà sua amante ma morirà ben presto in circostanze poco chiare.
Ma anche qui, le riflessioni di Renzi, Ida e altri personaggi, che vertono principalmente sull’oggetto dei loro studi (Hudson, Conrad, Melville e Tolstoj) non servono solo a caratterizzarli o a fare solo da contrappunto alla narrazione (come in molti libri recenti, a partire da quelle su Huysmans in Sottomissione di Houellebecq), ma sono dei veri e propri congegni che servono a portare avanti la storia, a suggerire corrispondenze e implicazioni (le differenze e corrispondenze tra Usa e Argentina, i ricordi personali e dei periodi di dittatura, il sogno di una società precapitalistica, le utopie...) e indurre il narratore a compiere dei passi decisivi per cercare di chiarire la morte di Ida, come in un giallo, e dare un senso agli eventi.

Del resto “Qualunque racconto è un giallo (...) Solo gli assassini hanno qualcosa da raccontare, la storia personale è sempre la storia di un delitto”, aveva già scritto Piglia in La città assente (p. 178), anche se i suoi libri, nonostante la loro frequente forma di romanzo di investigazione quando non di vero e proprio noir (come Soldi Bruciati), non contemplano mai la figura dell’investigatore come narratore o protagonista, ma figure che si potrebbero compendiare in quella del lettore. Nessuna contraddizione però: anzi, una conferma in più della prima affermazione, dal momento che se il romanzo di investigazione, che per lui è l’unico genere veramente moderno, nasce proprio con la figura dell’investigatore (il Dupin di Poe), questi è al contempo una delle prime incarnazioni del moderno lettore: di libri, ma anche delle tracce che sono disseminate nelle notizie, da quelle dei giornali (come nel caso inaugurale dei delitti della Rue Morgue), alla rete, come nel caso del Ralf Parker di Solo per Ida Brown. E lettori (e scrittori, o critici, o giornalisti: chi legge, scrive) sono anche molti personaggi: dal quasi onnipresente Emilio Renzi, al Junior protagonista di La città assente e ad altre figure non di secondo piano (come lo zio Maggi e l’esule polacco Tardewsky, ricalcato sul modello di Witold Gombrowicz che tanta importanza ha avuto per tutta una generazione di scrittori argentini, nello straordinario Respirazione artificiale), o gli oggetti delle loro indagini (l’Enrique Ossorio, traditore, politico e scrittore, capostipite della famiglia di signorotti locali ancora in Respirazione artificiale), per non parlare dei professori e scrittori dell’ultimo romanzo.
La morte di Ida Brown troverà un inizio di spiegazione a partire dalle sue sottolineature e note a margine della copia di L’agente segreto di Conrad da lei usata per il seminario che stava tenendo in quel semestre. È questa morte, probabilmente un omicidio anche se non sono chiare le modalità e soprattutto il movente, ma che potrebbe anche essere un incidente, che imprime una svolta alla trama: per cercare di capire cosa è successo, e che gli sembra che la polizia e l’Fbi gli nascondano, Renzi contatta un detective, Parker, che rappresenta una evoluzione della figura tradizionale così come si era venuta delineando nell’hard boiled americano a cui Piglia ha dedicato uno dei saggi più belli di L’ultimo lettore: non più qualcuno che agisce a proprio rischio e pericolo, ma uno che cerca informazioni e le mette insieme. Uno che non risolve più i casi, ma si avvicina ad essi raccontandone una versione, come dice lo stesso Parker (p. 145): un lettore, cioè, che diventa scrittore...
È attraverso di lui che Renzi arriverà ad avvicinarsi a una plausibile interpretazione dei fatti, senza però approdare a nessuna certezza.
Infatti, se a proposito di L’agente segreto Renzi afferma: “Non era la realtà a permettere di capire un romanzo, ma il romanzo a rendere comprensibile una realtà che, per anni, era rimasta indecifrabile” (p. 188), nemmeno questa decifrazione può dare accesso a una realtà ultima, in quanto a sua volta non può essere completamente decifrata, ma solo, di nuovo, raccontata. Come già evidenziato dai grandi libri di Gadda, i casi non si risolvono mai ai nostri giorni (nella letteratura odierna: in quella di Piglia, di sicuro). C’è sempre un residuo, un’ipotesi ulteriore che a sua volta ne suscita altre. È la visione paranoica, che si basa sul fatto che tutto può essere letto come indizio, come ha insegnato ironicamente Gombrowicz soprattutto nel capolavoro Cosmo, l‘ormai onnipresente teoria del complotto, che però in Piglia non dà luogo a rimuginazioni ossessive e contorte, ma viene distribuita nei differenti punti di vista dei personaggi e sapientemente manovrata dall’autore. La costruzione dei suoi libri, come lo stile, è della più grande lucidità. Il discorso che risolve, che chiude in una verità ufficiale è quello del potere, mentre la letteratura tiene aperte molte strade, fissa dei punti che non sono mai fermi, ma si raddoppiano sempre per dar luogo ad altre visioni della realtà, a ipotesi controfattuali, a sentieri che si biforcano e non si sa dove portano.

Il cambiamento dei tempi è quindi anche un cambiamento del lettore. Oltre a quello esemplificato dalla figura dell’investigatore, anche il lettore “tradizionale” (lo studioso, il critico, il professore, Renzi) ha subito una mutazione: se il primo legge la rete per scoprire, l’altro scopre dalla lettura (sua) di una lettura (di Ida) di un romanzo del passato (L’agente segreto di Conrad) gli indizi per capire cosa è, o meglio: cosa può essere successo. Si legge un testo sempre già letto. Si leggono letture.
Capire è istituire dei nessi, ma per farlo, “è necessario raccontare un’altra storia. O tornare a raccontare una storia, ma da un altro luogo e in un altro tempo. Questo è il segreto di ciò che c’è da leggere. E questo è quel che la letteratura, secondo Kafka, mostra senza spiegare” (L’ultimo lettore, p. 51).
Si tratta sempre, da lì, di costruire una trama, anche, ricordando sempre però che “la cosa più importante in una storia è ciò che non si racconta” (Introduzione all’edizione italiana di Respirazione artificiale, p. 8). La stessa trama che si ricostruisce a spezzoni e si racconta qui, con molte interruzioni, come su silenzi e interruzioni sono basati i romanzi di Piglia. “Solo nei film di Hollywood è sbagliato raccontare il soggetto; nei romanzi invece la trama è soltanto una guida, o meglio la mappa di un territorio che si va trasformando mano a mano che procediamo” (Ivi, p. 9).
Dei libri di Piglia si può, e forse si deve, raccontare la trama, perché una trama non c’è: non solo nel senso che non c’è trama al di fuori dall’atto di riassumerla e raccontarla (o che viceversa c’è sempre, perché non appena si mettono in fila due frasi una trama è già istituita, sia pure come storia possibile), ma nel senso che le storie da lui raccontate, oltre che spesso interrotte, si sovrappongono e si incrociano in vari modi e in punti diversi, e sono a loro volta oggetto di riflessioni e di ricostruzioni che variano da un personaggio all’altro e di cui nessun narratore esterno è in grado di tirare tutti i fili e chiudere il cerchio. Il famoso inizio di Respirazione artificiale diceva “C’è una storia?”, e continuava: “Se una storia c’è, inizia tre anni fa”. Ma una storia non c’è mai (come non c’è una vita: vedi l’inizio di Solo per Ida Brown: “In quel periodo vivevo varie vite, mi muovevo per sequenze autonome”), ce ne sono sempre tante quanti sono coloro che leggono e raccontano: e quindi una storia c’è sempre: non ci sono altro che storie. Il che non significa che non ci possa essere verità, o realtà, o solo esperienza...
Ma un cambiamento è intervenuto anche nello statuto dell’“eroe” centrale del romanzo, che, dice Piglia per voce di Nina, l’ottantenne esule russa vicina di casa amica di Renzi, se in passato è stato l’Avventuriero, e più tardi il Dandy, nel XXI secolo sarà il Terrorista, un uomo che “non uccide per interesse personale né per vendetta, [ma] per un’idea, come un filosofo platonico”, peraltro già preannunciato nel secolo precedente sia nel cinema che nel romanzo, a partire appunto dal citato L’agente segreto di Conrad, del 1907.
Anche il terrorista, che incarna il secondo elemento che per Piglia assieme all’enigma è costitutivo del romanzo di investigazione: il mostro (l’altro assoluto: scimmione, folle, fuorilegge o solo straniero che sia), è un lettore e uno scrittore alla ricerca di lettori: “il terrorista come moderno scrittore, l’azione diretta come patto con il Diavolo” (p. 129). I suoi attentati possono essere visti come una strategia che può essere riassunta così: “Uccidere delle “persone” per procurarsi lettori” (p. 129). Come sanno tutti i movimenti terroristici, attirare l’attenzione è capitale. “Il terrorismo è propaganda armata, un mezzo di comunicazione come qualsiasi altro” (p. 108). Solo il terrore puro può fare a meno della comunicazione. L’unica comunicazione contenuta nella violenza senza comunicazione, cioè senza che vi sia un interesse che vada al di là della volontà o del piacere di esercitarla, è la violenza stessa; l’unico effetto è il terrore. L’attenzione invece, come ha ben illustrato il filosofo Yves Citton, è la merce più ambita della nostra era caratterizzata dall’ipercomunicazione: e per il singolo (cittadino, compratore, destinatario) spesso è anche l’unico capitale spendibile. La capacità di attenzione è ciò che lo definisce. L’individuo è il soggetto potenzialmente attento, e la strategia più efficace per ridestare e tenere viva questa capacità è eccitare le sue passioni, il desiderio, e più ancora quella più forte di tutte, la paura. (Da notare invece che nel secondo romanzo di E. Vila-Matas, L’assassina letterata, si racconta il caso di un libro scritto apposta per uccidere il lettore a cui era destinato. Impresa meno ardua di quanto si potrebbe supporre tuttavia, dal momento che di fatto, pur senza volerlo, i libri che trionfalmente ci riescono sono la stragrande maggioranza.)

Il terrorista di Solo per Ida Brown, nominato Recycler da giornalisti e investigatori per il suo modo di agire e i messaggi che lancia, è modellato sulla figura di Theodore Kaczynski, noto come Unabomber, che tra i 1978 e il 1996 realizzò una ventina di attentati negli Stati Uniti, alcuni letali. Nel romanzo, quando viene identificato e arrestato, poco dopo la morte di Ida, si chiama Thomas Munk e come l’Unabomber reale è genio matematico e logico precoce, vincitore di premi prestigiosi e giovanissimo insegnante a Berkeley negli anni ‘60 dove appunto Renzi scoprirà che ha conosciuto Ida Brown. Come il suo corrispettivo reale, anche Munk si ritira dal mondo a vivere come un eremita autosufficiente al ritorno del fratello Peter dal Vietnam, che poi diventerà scrittore e sarà colui che lo riconoscerà come autore del “Manifesto” da lui inviato a editori e giornali come condizione per cessare gli attentati e lo tradirà. (Il tema del traditore, di ascendenza borgesiana, è costante – sia detto di passaggio – nei libri di Piglia, che lo declina in vari contesti e modi con estrema sottigliezza.)
Il susseguirsi degli attentati senza rivendicazione reclamava una lettura offrendo però solo una debole chiave d’accesso (le buste esplosive, sigle enigmatiche e materiali usati...); ma più questa si rivelava debole, più cresceva, insieme alla necessità di trovarla, il desiderio di sapere, l’ansia della decifrazione: sventare altri attentati ma anche dare un nome, capire, rassicurarsi. Conoscere l’autore. (L’anonimato e la pseudonimia sono uno stimolo irresistibile per la curiosità del lettore, come si sa...) L’autore, e i suoi eventuali complici. Se ne aveva. Cosa molto probabile (e forse Ida era uno di essi, magari involontaria, non del tutto consapevole, senza contare che “in giro ci sono molti gruppi ecologisti che sarebbero stati dispostissimi ad aiutarlo”, p. 202), anche se dopo la cattura tutto sembra essere attribuito al solo Munk, con buona pace di tutti: perché, come afferma anche il funzionario dell’FBI che accredita questa versione, uno psicopatico isolato è un caso clinico; un gruppo, anche limitato, è invece un problema sociale – e implicitamente, quindi, l’ammissione di un’imperfezione dell’organismo che per eccellenza si vuole perfetto e catafratto, lo Stato, con i suoi apparati. Si sa che il confine tra dissidenza e malattia mentale è sottile e tutti i poteri tendono a renderlo poroso, anche quando non lo cancellano completamente come fanno i regimi totalitari. Per opporsi al benefattore universale bisogna essere pazzi, o criminali, e quindi l’oppositore va soppresso, o quantomeno, per non smentire la propria umanità, rinchiuso nei luoghi dove possa essere neutralizzato o redento: lager o manicomi.
L’assassino si nasconde, o confonde, con la massa degli invisibili, dalla quale pure si isola: come essa è composta di anonimi sconosciuti, così egli, nella società di massa e della sorveglianza totale, si rende anonimo, nasconde il suo segreto, che nel caso di Recycler viene poi strumentalizzato alla diffusione delle sue idee: il segreto regge non solo le sue azioni, ma lo Stato stesso contro cui egli si rivolta, uno stato doppio, che è basato insieme sulla proclamazione della libertà e sulla sorveglianza totale, sulla necessità di conoscere ogni segreto tenendo però celati i propri, e quindi sfidando chi non vuole esserne complice a cercare di rivelarli e a diffonderli in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili: che poi – e sta qui la loro forza ma infine anche la loro sostanziale debolezza, cioè la radice della loro sconfitta –, sono gli stessi del suo avversario. E così tendono essi stessi a identificarsi. “Il potere politico è sempre criminale”, diceva un personaggio di La città assente (p. 79), come lo è chi lo contrasta. Ma questi ne incarna anche alcuni valori di fondo. Munk, il terrorista, il pericolo pubblico n. 1, è anche “un eroe americano nel vero senso del termine: l’individuo con un’educazione superiore, l’intellettuale di alto prestigio accademico, che sceglie di abbandonare ogni privilegio e si ritira a vivere in un bosco [...e] decide di mostrare che la ribellione è possibile, e che un uomo da solo può mettere in scacco l’FBI” (p. 212), e come tale hai i suoi fan e estimatori nei campus e nell’esercito dei “radicali”, emarginati e “ribelli” che fanno parte da sempre della società americana, e persino in prigione, dove gode della stima di tutti.
Come Munk, anche Ida, “interessata alla tradizione di quegli scrittori che si opponevano al capitalismo da una posizione arcaista e preindustriale. Populisti russi, beat generation, hippy e, oggi, gli ecologisti...” (p. 18), “era una star del mondo accademico” (p. 17), che a modo suo essa terrorizzava e combatteva, non facendo distinzione tra pensare e combattere, “due verbi [che] vanno a braccetto” (p. 18). Pur rimanendone all’interno e godendo dei benefici della notorietà, Ida, da marxista qual era, era consapevole che il mondo accademico non rappresenta il meglio della società, non la osserva e giudica olimpicamente dall’alto e se aspira a cambiarla e/o a guidarla, è solo perché ne incarna alcuni dei meccanismi più profondi: a partire dalla feroce competizione e dalla sottaciuta violenza dei rapporti, che non a caso Recycler, che da quello stesso mondo proviene, alla lettera fa esplodere.
“Le università sono i nuovi ghetti, i luoghi di violenza psicologica della modernità. ... Pacifici ed eleganti, i campus sono concepiti per escludere esperienza e passioni ma, sotto la superficie, scorrono ondate di collera intestina: la violenza terribile degli uomini educati” (pp. 30-31). (Del resto nemmeno Piglia si risparmia la giusta dose di perfidia, minima, impercettibile a volte, quanto velenosa, sempre con l’accortezza però di farla enunciare da coloro stessi che ne sono i bersagli). Non è quindi sorprendente che questa violenza a volte si riversi anche fuori e che da fuori vi ritorni (basti vedere il gran numero di stragi nei campus delle high school o dei college, e il fatto che praticamente la totalità degli attentati dell’Unabomber reale, come di quello di Solo per Ida Brown, abbia avuto per vittime docenti o persone che lavoravano in campi tecnologici e culturali.

Ma anche Ida, proprio perché personaggio pubblico, si riservava un territorio di segreto e separazione: “saremo amanti clandestini”, impone a Renzi appena inizia la loro avventura (p. 49). Come se, per vivere, una vita non bastasse, ma ce ne volesse almeno una seconda, o altre ancora. “La doppia vita fa parte della cultura di quel paese”, afferma Renzi (o Piglia?, p. 51). Come se, non solo nell’amore, fosse indispensabile il segreto, nascondersi, riservarsi uno spazio invisibile, anonimo, cifrato, forse proprio in virtù del fatto che la nostra, come ha scritto Riccardo Venturi, “è l’epoca dell’open secret, come l’ha definita Pamela Lee, di un’invisibilità visibile al cuore delle politiche d’informazione, di un segreto che annuncia la sua clandestinità mostrandosi in pubblico”.
Da una parte quindi la clandestinità è impossibile, dall’altra è necessaria: “C’è un’unica via di scampo: restare da soli, in un luogo isolato... questa è l’era degli uomini soli, delle cospirazioni individuali, dell’azione solitaria. Possiamo resistere solo nascondendo i nostri pensieri, mantenendoli invisibili, confondendoli nella moltitudine” (pp. 222-3). Le idee, essendo invisibili, sono “l’ultimo rifugio della ribellione”. Il problema è però che, quanto più queste idee sono forti, tanto più forte è l’esigenza di diffonderle. E diffonderle comporta dei costi. Anche in vite umane. Dice Munk a Renzi che lo va a visitare in carcere: “Ma non deve credere che i morti mi siano indifferenti, proseguì. Sono miei pari, avrei potuto essere uno di loro. Grandi scienziati, mascalzoni fatti e finiti, uomini sensibili... Dimenticavano – o non volevano vedere – le conseguenze dei loro atti. Il male è questo: non farsi carico delle conseguenze dei propri atti. Le conseguenze, non i risultati” (p. 227). Ma non è detto che facendosi carico delle conseguenze il male sia evitato, o redento.
Munk, che nelle sue ricerche si era occupato delle “condizioni necessarie per inferire la verità” (p. 150), non si preoccupa invece di quali saranno quelle relative alle tesi sulla logica distruttiva del capitalismo che lui intende divulgare come se i modi della loro diffusione fossero di nessun conto. Il contro-complotto con cui intende reagire al complotto su cui si basa la società obbedisce alla sua stessa logica. Scrive Piglia nella Postfazione all’edizione americana di La città assente: “Fiction della paranoia ... La politica entra nel romanzo contemporaneo attraverso il modello del complotto, attraverso la narrazione di un intrigo, anche se tale complotto è privo di qualsiasi esplicita connotazione politica. È sulla forma in sé che si fonda la politicizzazione del romanzo” (pp. 194-5). Nei romanzi di Piglia però la connotazione politica, anche se non sempre marcata, e quasi mai esplicitamente, è quasi sempre presente. In Solo per Ida Brown, tuttavia, lo è, con l’esplicitezza di temi che però non si fissano mai in una verità definita e definitiva.
Perché non solo si deve constatare, come diceva Maggi in Respirazione artificiale, che “un uomo solo fallisce sempre”, ma ciò che ci si deve chiedere è “a cosa serve o al servizio di cosa è questo scacco individuale”. Il romanzo è uno dei modi per farlo. Piglia, in questo libro come negli altri, usa eventi o figure derivati dalla storia e dalla cronaca e li mette alla prova della varietà dei punti di vista e delle possibilità immaginative (e formali) che solo la finzione, e la sua verità, offrono.
Anche quando si riferisce a figure, documenti (libri e giornali) o eventi reali, Piglia si prende sempre la libertà di inventare, a seconda di ciò che è funzionale a quanto sta scrivendo. Quando mette in scena figure storiche, non è per ancorare ciò che narra alla realtà, ma al contrario perché solo attraverso l’invenzione il reale, anche quello storico, diventa comprensibile, e forse addirittura viene prodotto: nel senso che se ne fa esperienza e solo l’esperienza rende percepibile e conoscibile, cioè reale, ciò che accade, il mondo.
Alla figura storica, senza contraddire quanto si sa di essa e di ciò che ha fatto e scritto, e spesso proprio utilizzandone alcuni elementi, vengono attribuite parole e azioni che avrebbero potuto benissimo dare o dire, se solo si fossero trovati nelle circostanze descritte nel testo e/o la loro vita a un certo momento avesse scartato anche solo di un grado in altre direzioni o mondi possibili, non come ipotesi controfattuali, ma come segmento di una vita che peraltro sarebbe rimasta identica a quella che conosciamo, ma ricevendone una nuova luce e un di più di conoscenza. (Un esempio è la frase del diario di Kafka a partire dalla quale, in Respirazione Artificiale, l’esule polacco dice di aver scoperto un incontro dello scrittore in un caffè di Praga con un giovane esaltato che poi diventerà il Führer e che segnerà in modo decisivo la sua produzione successiva, il mondo che in essa prenderà forma e la Stimmung che la pervaderà...)
La verità della finzione è più importante della fedeltà alla realtà. La verità, semmai, si può pensare di perseguirla solo attraverso la fedeltà alle regole della finzione, a dove conducono le storie con le loro sospensioni, i loro buchi, segreti o semplicemente cose non dette, che ne costituiscono peraltro l’aspetto più importante. L’enigma non è solo quello che i personaggi cercano di rivelare, ma soprattutto quello che circola nelle storie tra i segmenti e le versioni che le costituiscono, e più ancora quello che, mai chiarificabile del tutto, e forse nemmeno definibile, le costituisce, e con loro la realtà che in esse prende forma, la conoscenza che ne abbiamo e l’esperienza che ne facciamo. Come viviamo, insomma.
Nota di lettura
I libri di Ricardo Piglia sono equamente suddivisi tra Feltrinelli (Soldi Bruciati, tr. it. Pino Cacucci, Guanda 2000, e ora Feltrinelli 2008; L’ultimo lettore, tr. it. Alessandro Giannetti, 2006; Bersaglio notturno, tr. it. Pino Cacucci, 2011; Solo per Ida Brown, tr. it. di Nicola Jacchia, 2017) e le edizioni Sur (Respirazione artificiale, tr. it. Gianni Guadalupi, 2012; La citta assente, tr. it. Enrico Leon, 2014; e i racconti, L’invasione, tr. it. Enrico Leon, 2015). Da segnalare anche l’importante saggio “Romanzo e complotto”, in Nuova prosa, N. 46, marzo 2007, Greco&Grecoeditori. Il sito di Sur è ricco di testi, testimonianze e interviste di e sull’autore argentino. Numerosi e di grande interesse sono i filmati di interviste e trasmissioni televisive reperibili su Youtube. Il “Manifesto” di “Unabomber” Theodore Kaczynski, La società industriale e il suo futuro, è stato tradotto per Stampa Alternativa ed è reperibile in rete qui. Per L’agente segreto di Conrad si veda la trad. di Richard Ambrosini, Mondadori, 2010, con un saggio di Virginia Woolf. Del capolavoro di Witold Gombrowicz, Cosmo, è appena uscita per Il Saggiatore una nuova traduzione di Vera Verdiani, a cura di Francesco Cataluccio. Dei testi di Yves Citton vedi soprattutto Pour une écologie de l’attention (Seuil, 2014). L’assassina letterata, di Enrique Vila-Matas, del 1977, è stato tradotto da. E. Pagani, Voland, 2004. La citazione di Pamela Lee è contenuta in un articolo comparso su Artforum, maggio 2011, citato da Riccardo Venturi in Il corpo di internet. L’arte di Trevor Paglen, di prossima uscita su doppiozero.